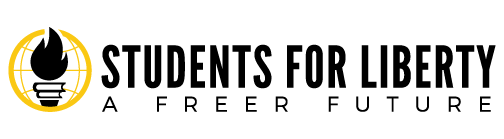Tag: Politica
-
L’indifferenza sugli inseguimenti di liberi cittadini con droni ed elicotteri: un tunnel senza fine e senza luce
-
La spesa attraverso gli stimoli non fermerà le ricadute economiche del Coronavirus
-
Coronavirus. Criticare il Governo non vuol dire essere “sciacalli”
-
Coronavirus, “caccia al disinfettante”. Prezzi alle stelle per mascherine e prodotti igienizzanti.
-
Fuori dal Salone
-
Il fallimento dell’istruzione pubblica obbligatoria
-
Le conseguenze della centralizzazione: il down di Facebook
-
Lasciate correre i monopattini elettrici!