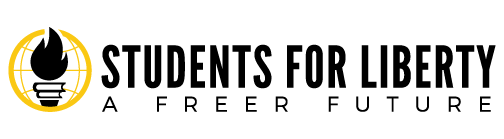Tag: Libero Mercato
-
Uno spettro si aggira per l’Italia della resurrezione: lo Stato Imprenditore
-
Ma sul calmiere dei prezzi Diocleziano non vi ha insegnato proprio niente?
-
La spesa attraverso gli stimoli non fermerà le ricadute economiche del Coronavirus
-
Coronavirus, “caccia al disinfettante”. Prezzi alle stelle per mascherine e prodotti igienizzanti.